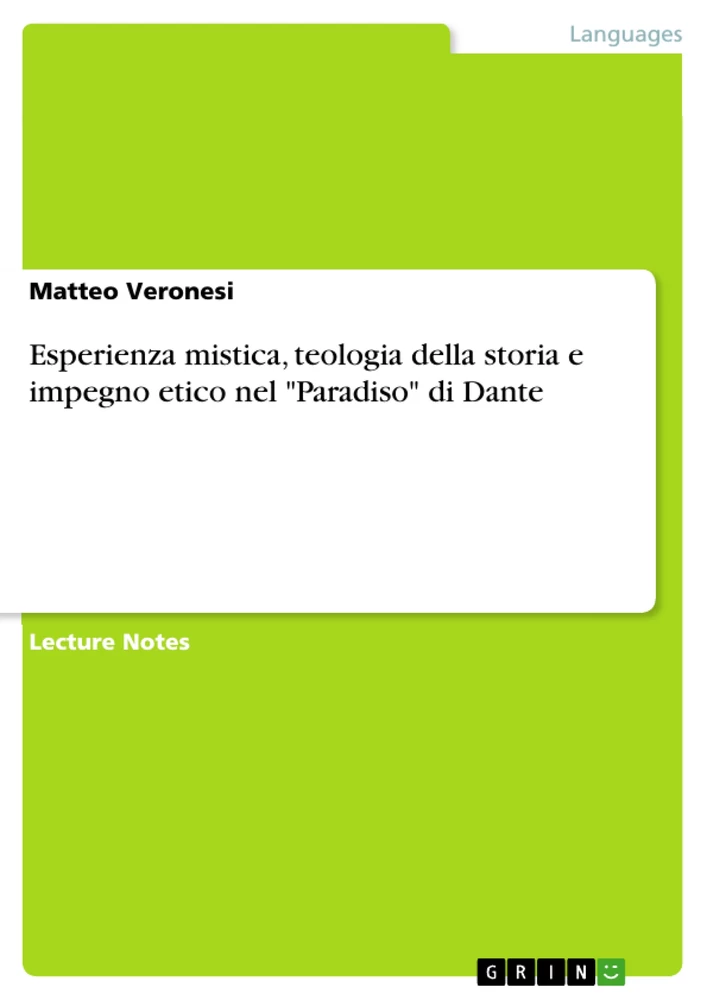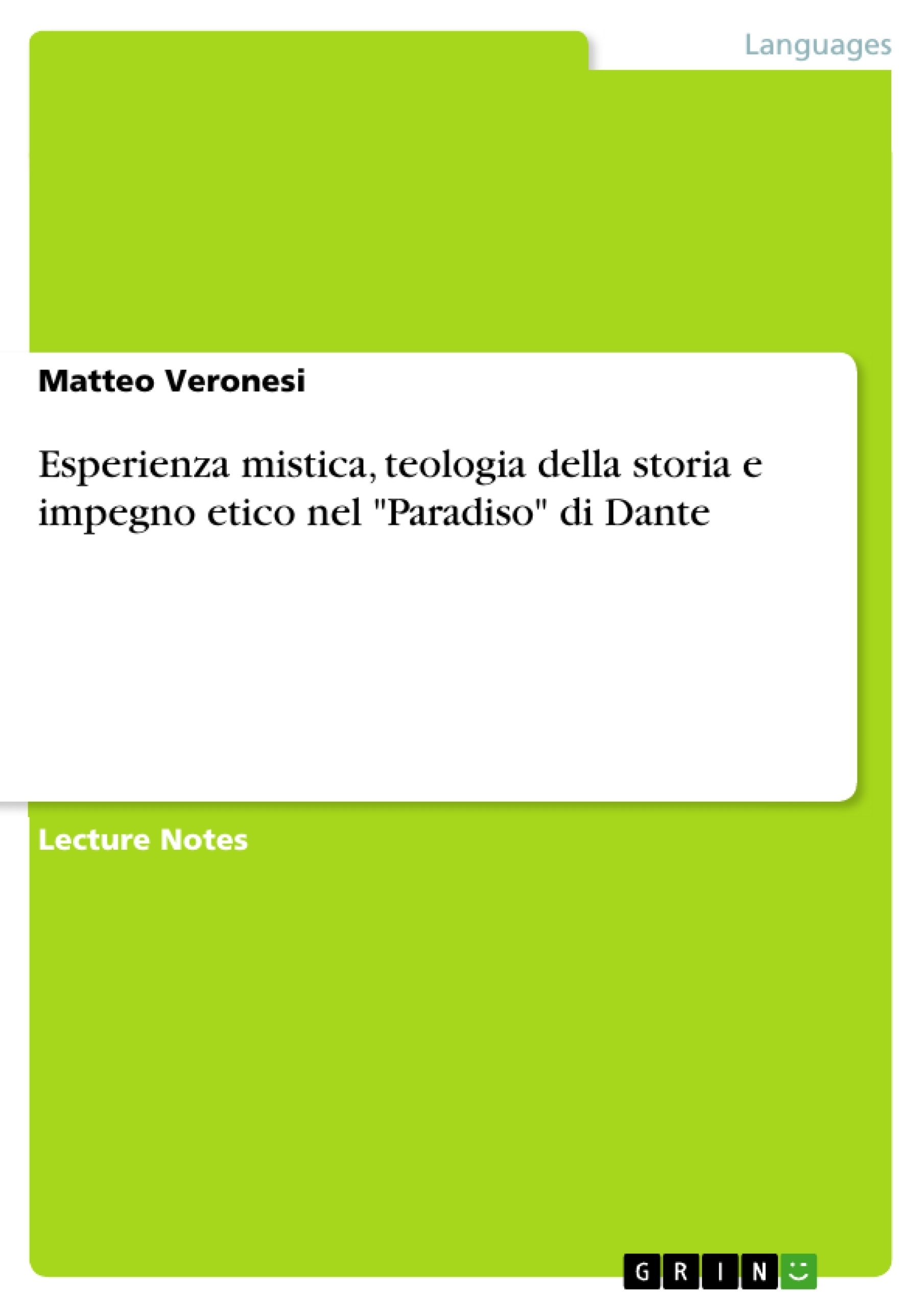La visione dantesca della silenziosa armonia, della muta musica, tutta intellettuale, delle sfere celesti fonde, in certo modo, una componente aristotelico-tomistica con un'eredità neoplatonica. Nel celebre proemio, Dio è «Colui che tutto move», cioè il Motore Immobile, che con la sua perfezione attrae a sé tutti gli enti e tutte le creature, che si muovono «per lo gran mar de l'essere», nel vastissimo pelagus Substantiae infinitum («oceano infinito della Sostanza») di cui parlava Tommaso d'Aquino.
Inhaltsverzeichnis
- ESPERIENZA MISTICA, TEOLOGIA DELLA STORIA E IMPEGNO ETICO NEL PARADISO DI DANTE
- La visione dantesca della silenziosa armonia, della muta musica, tutta intellettuale, delle sfere celesti fonde, in certo modo, una componente aristotelico-tomistica con un'eredità neoplatonica.
- Nel celebre proemio, Dio è «Colui che tutto move», cioè il Motore Immobile, che con la sua perfezione attrae a sé tutti gli enti e tutte le creature, che si muovono «per lo gran mar de l'essere», nel vastissimo pelagus Substantiae infinitum («oceano infinito della Sostanza») di cui parlava Tommaso d'Aquino.
- Nel contempo, però, la «gloria di Colui che tutto move» è anche, come Dante stesso chiarisce nell'Epistola tredicesima a Cangrande della Scala (la quale, pur se di discussa autenticità, sancisce la dedica della terza cantica al signore di Verona, vicario imperiale, e in pari tempo ne offre preziose chiavi di lettura), divinus radius, sive divina gloria, «
- Qui Dante si avvicina alla mistica e alla metafisica della luce, di origine neoplatonica, e diffuse nella filosofia medievale, sia cristiana (Dionigi lo Pseudo-Areopagita, Riccardo di San Vittore, Roberto Grossatesta, Bonaventura da Bagnoregio), sia islamica (il Libro della Scala, che narra il viaggio celeste di Maometto, e presenta molte affinità con la narrazione dantesca).
- La luce, in termini platonici, rappresenta la purezza dell'essere, della trascendenza, del Divino; le tenebre sono, invece, simbolo2 delle impurità e delle scorie della materia, del corpo, della conoscenza sensibile (la stessa selva oscura del primo canto dell'Inferno potrebbe rappresentare, oltre e più che il peccato, come banalmente si interpreta, proprio l'inganno della conoscenza e delle tentazioni legate alla materia e al corpo, tanto più che in greco hyle, come ricordavano nel dodicesimo secolo i filosofi neoplatonici della scuola di Chartres, significa sia \"selva\" che \"materia\", e per questo veniva contrapposta dialetticamente al Noys, all'Intelletto che si appressa al divino attraverso la conoscenza razionale e spirituale).
- Dante sembra fondere la nozione aristotelico-tomistica del Motore Immobile con quella neoplatonica del \"ritorno all'Uno\", in base alla quale tutte le anime, che vivono sulla terra come in esilio, desiderano tornare al loro Padre celeste, alla loro origine prima, al Bene supremo ed assoluto, con una \"fuga del solo verso il Solo\". Al tema mistico si lega strettamente quello dell'ineffabile. «E vidi cose che ridire / né sa né può chi di lassù discende».
- Qualcosa di simile si legge nelle pagine in cui San Paolo, nelle Lettere, rievoca la propria ascesa al cielo del Sole, durante la quale aveva udito arcana verba, parole enigmatiche, arcane, di origine sovraumana, che a nessuno, sulla terra, è lecito riferire o interpretare.
- Il razionalismo aristotelico-scolastico è, al culmine della visione, oltrepassato e trasceso (ma non per questo eliminato o privato di valore) dalla alienatio mentis, dall'excessus mentis dei mistici, ossia da uno slancio interiore che viola i limiti e i confini del corpo e dell'esperienza per immergersi totalmente nella divinità: una unio mystica o, come lo chiamerà Spinoza nell'era della Controriforma,3 un amor Dei intellectualis, «amore intellettuale di Dio».
- <
- Nel canto trentesimo, la mistica della luce assume la forma della \"visione metamorfica\", fluente, cangiante, mutevole. Dante qui si ispirò forse all'opera La luce fluente della divinità della scrittrice mistica medievale Matilde di Magdeburgo, che alcuni identificano con la Matelda del Purgatorio, mediatrice fra Virgilio e Beatrice, fra una sapienza umana e terrena, per quanto nobile ed elevata, e una sapienza celeste e spirituale, e incarnazione (secondo Pascoli) dell'arte poetica, che sintetizza concezione intellettuale e perizia tecnica, idea e forma. Quella dell'Empireo, il cielo supremo, è «
- La terzina XXX, 40-42 («
- Significato analogo, a livello di semiologia della musica, può avere il ciclico, periodico e ricorsivo tornare su una stessa nota o uno stesso gruppo di note che si ravvisa nelle melodie del canto gregoriano (spesso riprese come tenor, come voce di base, nella polifonia dell'ars antiqua e dell'ars nova, anch'essa non ignota a Dante).
- Analoghe strutture stilistiche iterative e ricorsive (anche se qui con un maggior tasso di variatio) si trovano, per esprimere la stessa natura di \"pensiero di pensiero\" propria dell'Essere Sommo, in XXXIII, 124-126: «
- Siamo arrivati, così, al canto conclusivo, in cui vengono a sintesi tutti i motivi principali della visio mystica e della beata visio che il poeta ha disseminato per tutta la terza cantica.
- Maria Vergine è un paradosso assoluto, una sfida estrema e irriducibile che la fede pone alla ragione: «Vergine madre, figlia del5 tuo figlio», dice il verso iniziale, con due antitesi nette ed eloquenti.
- In pari tempo, ella è mater et mediatrix, mediatrice presso Dio delle preghiere degli uomini. Proprio grazie alla mediazione di Maria, Dante è ammesso a contemplare il Divino, in cui si raccolgono e si assommano, come le pagine infinite di un libro eterno, tutti gli aspetti, le forme, le potenzialità e gli enti disseminati per il cosmo (una metafora simile - quella del \"Libro di Luce\" - si trovava nell'islamico Libro della Scala).
- I <
- Nell'ultimo canto, Dante assomma due fra i più profondi ed insondabili misteri della fede cristiana: la maternità verginale di Maria e il Dio uno e trino. E di fronte alla visione del Divino, anche la sua \"alta fantasia\", anche le sue straordinarie facoltà immaginative ed espressive devono dichiararsi vinte e sopraffatte. La cantica, apertasi sotto il segno dell'ineffabile, sempre sotto di esso si chiude. La luce sconfinata nell'accecamento, la parola nel silenzio. E su tutto regna l'«
- Nel canto terzo spicca la figura di Piccarda Donati, strappata con la forza dalla quieta e riparata «dolce chiostra» del convento (la quale, commentava Benvenuto Rambaldi, è «ombra del Paradiso>>, mentre il mondo esterno è «inferno dei viventi») e costretta con la"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die mystische Erfahrung, die Theologie der Geschichte und das ethische Engagement im „Paradiso“ Dantes. Er analysiert, wie Dante in seiner Beschreibung des Himmels eine aristotelisch-thomistische Sichtweise mit einem neoplatonischen Erbe verbindet. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der „luce divina“ als Symbol für die Reinheit des Seins und die Rückkehr zum Göttlichen.
- Die Verbindung von aristotelisch-thomistischer und neoplatonischer Philosophie in Dantes „Paradiso“
- Die Bedeutung der „luce divina“ in der mystischen Erfahrung und der Theologie der Geschichte
- Die Rolle des „Motore Immobile“ als Ursprung und Ziel aller Schöpfung
- Das Ineffable und die Grenzen der menschlichen Sprache und Vernunft
- Die Verbindung von rationaler und intuitiver Erkenntnis in der mystischen Erfahrung
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Analyse der Danteschen Vision des Himmels als Ort der „silenziosa armonia“ und der „muta musica“, die von einer aristotelisch-thomistischen Sichtweise beeinflusst ist. Er betont die Rolle Gottes als „Motore Immobile“, der alle Dinge anzieht und die Schöpfung in Bewegung setzt. Der Text stellt fest, dass Dante sich in seinen Beschreibungen der „luce divina“ der neoplatonischen Metaphysik nähert. Er diskutiert die Bedeutung der „luce divina“ als Symbol für die Reinheit des Seins und die Rückkehr zum Göttlichen. Die Kapitel befassen sich auch mit der Rolle der „alienatio mentis“ in der mystischen Erfahrung und zeigen auf, wie Dante durch seine mystische Vision die Grenzen der Vernunft transzendiert. Die Kapitel erforschen die Beziehung zwischen rationaler und intuitiver Erkenntnis und diskutieren die Grenzen der menschlichen Sprache und Vernunft, wenn es um die Beschreibung des Göttlichen geht. Der Text beleuchtet verschiedene Figuren und Begebenheiten im „Paradiso“, um die mystischen Erfahrungen Dantes zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Dante, „Paradiso“, Mystik, Theologie, Geschichte, „luce divina“, Motore Immobile, neoplatonische Philosophie, aristotelisch-thomistische Philosophie, Ineffable, „alienatio mentis“, unio mystica, amor Dei intellectualis, Erkenntnis, Sprache, Vernunft, Himmelsvision, „visione metamorfica“
- Citation du texte
- Matteo Veronesi (Auteur), 2018, Esperienza mistica, teologia della storia e impegno etico nel "Paradiso" di Dante, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446236